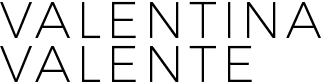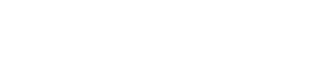Lo stile dell’anatra

Imparare lo stile dell’anatra, secondo lo scrittore napoletano Raffaele La Capria, è il fine di ogni scrittore. Ampliando, è il fine di ogni attività artistica: quello stile lieve e naturale come il movimento dell’anatra, che però richiede la fatica delle zampette palmate che lavorano sott’acqua, ma non si vedono. «Nello stile dell’anatra è importante la souplesse, che fa apparire naturale una semplicità che è stata faticosamente raggiunta, una semplicità che non esclude la complessità, anzi che deriva da una consapevolezza di quella. La semplicità è un punto di arrivo, non di partenza.»
La partenza
Il babbo dipinge nel suo studio, ascoltando a ripetizione, per quattro, sette, dieci volte di seguito lo stesso disco finchè non dà l’ultima spatolata alla tela, non distratto da noi bambini e dai nostri giochi rumorosi, dalle nostre corse per la casa: risuonano il violoncello di Rostropovic e il concerto di Sostakovic, il violino di Grumiaux e Paganini, o quello demoniaco di Ferras con il concerto in rem di Sibelius. Sono i suoni che sento familiari e che imito, cantare con la voce di un violino. I miei primi maestri di canto sono stati Rostropovic, Grumiaux, Menuhin, Ferras. Solo che loro non lo sapevano. Le acciaccature le imparavo dal III movimento del concerto n. 4 di Paganini suonato da Grumiaux, l’attacco del suono da Ferras, i filati da Menuhin. Verso i sei anni cominciai a studiare davvero il violino, ma invece di suonarlo mi veniva più naturale cantarlo. Imitare il violino, essere il violino, è non poterlo suonare. Impossibile da suonare, ma esserlo, sì, era proprio un godimento. Cantarlo. La voce mia, che usciva da me, era il suono del violino, del cello, dell’aria, della rosa che fiorisce e appassisce; imitavo tutto e tutti, con un pò di preoccupazione della mia famiglia quando avevamo ospiti. Dopo anni di inutile studio sul violino, lasciai quello strumento per cui non avevo nessun talento e continuai a cantare. Ho trascorso molte estati a Venezia dalla mia nonna paterna, Amalia Drusi Valente: lei è stata la mia quinta maestra, fin verso i 14 anni. La nonna era diplomata in pianoforte e canto con Toti dal Monte. Mi ha insegnato a “non sigar” (non gridare) mai, una certa eleganza nel portamento e l’amore per i cappelli e le maschere. Durante l’anno, poichè abitavamo lontane, mi dava lezioni di solfeggio e teoria per corrispondenza e mi consigliava anche cosa leggere. Purtroppo era appassionata di D’Annunzio.
E dopo, durante l’adolescenza, ho continuato a studiare con altri maestri: sono stati anni di studio pazzo, di dedizione totale, di concentrazione, di allenamento dei muscoli delle mie zampette palmate alla ricerca della semplicità e della souplesse.
La souplesse dello stile dell’anatra è, nel canto, il “legato”, che distingue un cantante che ha scuola dal dilettante.
E poi, prendendo a prestito ancora una metafora da La Capria, ho ricercato per anni il segreto del tuffo perfetto (nel tuffo importante è la perfezione della figura, «il fattore rischio e la necessità di un calcolo istintivo e insieme razionale», e «la capacità di far convergere il tutto verso un unico punto focale»). Per assumermi il rischio di cantare Lulu, imparare a tuffarmi bene è stato fondamentale.
Il gusto e la tendenza all’imitazione dei suoni che ho sempre avuto fin da piccola (ma quale bambino, lasciato un po’ stare, non ha quella predisposizione? Che fortuna avere tanti fratelli, essere lasciata abbastanza in pace a sperimentare) mi ha aiutato nel mio lavoro: aumentare la gamma delle voci, delle maschere, attraverso l’imitazione. Essere dimentichi di sè, smantellare l’io per osservare, conoscere e amare le cose, il mondo, tutto quello che è esterno a noi, passare attraverso la cruna dell’ago. Non è questo un miracolo concesso forse solo agli artisti? Ai poeti, ai pittori, ai musicisti…la metamorfosi. Metamorfosi per affrontare un pericolo, un imbarazzo, la timidezza, il disagio di vivere, ma anche per procurare piacere e sollievo. Essere qualcun’altro o qualcos’altro e vedere il proprio sè con più acuto sguardo, essere oltre, oltre l’intelletto, essere amore – per sè, per gli altri, per l’universo. Questi sono i miracoli dell’arte, della musica. Andare oltre, “al di là dell’uomo” (Uebermensch!): essere superuomini almeno in scena, è già qualcosa.
Valentina Valente
Da «Una pagina di diario», 21 febbraio 2012